
IL VUOTO COME ORIGINE DI FENOMENI ARTISTICI
di Chiara Padrini
Spesso ci troviamo spiazzati di fronte alle molteplici forme artistiche espresse in Oriente, specificatamente a Cina e Giappone.
Bonsai, Suiseki, Ikebana, Karesansui, Cerimonia del tè, arte? Passi per Haiku o Sumi-e (pittura a inchiostro) dove pittura e poesia sono considerate in occidente forme d’arte, ma per le altre espressioni?
Si tentano allora spiegazioni più o meno improvvisate e posticce, a guardar bene improponibili.
Si sente dire: in Giappone la parola arte è usata anche per quelle attività che noi consideriamo artigianali, così automaticamente, applichiamo alle parole arte e artigianato i nostri significati.
A dire il vero, non cerchiamo una spiegazione, o svolgiamo un’indagine, ma infliggiamo una squalifica. NOI, sottinteso che sappiamo bene cos’è l’ARTE, non ci permettiamo di “elevare” a dignità artistica qualcosa che, pur tecnicamente raffinata ed espressivamente eccellente, esula dalle nostre classificazioni occidentali e dal concetto di estetica che le ha generate.
Questo perché ci manca quell’anello iniziale, quella decifrazione dei concetti metafisici che hanno prodotta quella che, impropriamente, definiamo “estetica orientale”. Impropriamente perché si dovrebbe invece definire “l’estetica del vuoto”.

Le due filosofie di vita nate dal Buddismo antico e sviluppatesi in Cina (Buddismo Chan) e in Giappone (Buddismo Zen) hanno interessato ed influenzato tutte le arti, coltivando la funzione del vuoto, che le ha impregnate in modo determinante.
Il quesito del vuoto è basilare in tutta l’arte orientale, ma la nostra parola “vuoto” corrisponde concettualmente a quella orientale?
Secondo M. Koyama esistono vari ideogrammi che significano vuoto, qui per semplificazione considero il “MU” .
Dice Koyama: “MU ha innanzi tutto significato privativo, cioè indica la non presenza di qualcosa, il vietare qualcosa, o il suo non esserci più..”
Mayumi Koyama – elementi di storia dell’arte ed estetica giapponese – Milano 1987
Non è quindi un valore assoluto, ma piuttosto una dinamica e un metodo che annulla i pregiudizi per creare un vuoto in cui tutto si mostra nella sua verità.
I testi buddisti contenuti nel “Canone buddista” producono innumerevoli riflessioni sul vuoto che si possono sintetizzare in questa sentenza:
“Contempla il mondo con vacuità, sempre restando rammemorante”.
La pratica meditativa è espressa nel significato di “contemplare”. Azione che porta all’ascesi: trascendendo e modificando il contemplato, dove la “vacuità” è il prodotto di una meditazione vigile.
Questo atteggiamento è fondamentale per comprendere perché siano ricercati, nell’esecuzione di forme artistiche, stati di grande concentrazione in essere solo col raggiungimento del vuoto, ottenibile con la pratica della meditazione.
Il vuoto, quindi, come sorgente prima di forme d’arte che scaturiscono da “esperienze” e non da “teorie”, esperienza del vuoto realizzata con la pratica della meditazione. Difficile da comprendere per noi occidentali, come da questa esperienza, possano nascere tante forme d’arte così vive e vitali. Non tentare però di comprendere le funzioni creative del vuoto, permettete il gioco di parole rappresenta un “vuoto” incolmabile.

Definire cos’è l’estetica del vuoto è un problema non da poco.
Va tenuto però presente, se parliamo di estetica, che l’estetica considerata in occidente come disciplina, sia in Cina che in Giappone non è mai esistita e solo di recente, in seguito alla vasta occidentalizzazione di quei paesi, si è introdotta.
Non troviamo infatti quei connotati “scientifici” e “teoretici” che fanno parte dell’estetica occidentale. Per esempio: prospettiva, regola aurea, dei terzi, sequenza Fibonacci e quant’altro, sono sviluppi teorici di un’estetica “regolamentata” che non è immaginabile né riscontrabile nelle culture di cui ci occupiamo. Applicarle per adattare il pensiero orientale al nostro è una forzatura non solo incongrua, ma fuorviante al “cuore” dell’estetica di quei paesi. La teoria e la pratica sono fasi culturali tipicamente legate al pensiero occidentale, mentre in oriente:
“ogni cosa è già un’azione ed ogni azione possiede in sé energia e valori spirituali”
M. Granet, Il pensiero cinese, trad. it. 1971- W. Th. De Bary et al. Sources of Japanese Tradition New York 1958)

G.C. Calza ,uno dei maggiori esperti di cultura giapponese italiani, scrive:
“La civiltà giapponese è un ricettacolo di mezzi toni e sfumature, di spazi vuoti che non vanno subito colmati, ma goduti come sono, di un’infinità di arti che hanno come scopo non il prodotto estetico, ma l’atto che arricchisce il rapporto. Rapporto con le persone, rapporto con la natura, rapporto con le cose”
Calza: Junichiro Tanizaki, Libro d’ombra Milano 1982
Dobbiamo quindi evitare di considerare il Taoismo e il Buddismo Chen o Zen dottrine dalle quali vengono estratte forme di esperienza estetica; “la scienza del bello”, in veste teoretica, non ha senso.
Nella cultura cinese e giapponese “bello” come idea non esiste perché non è possibile che ci sia un individuo che contempla o crea, e una bellezza da contemplare o da creare.
Occorre trovare la via che arriva all’essenza di queste religioni , scoprire il loro “centro”, da cui si irradia l’energia che genera le forme di esperienza estetica.
Il VUOTO è questo centro, il suo nucleo. Non l’IDEA del vuoto ma l’ESPERIENZA del vuoto.

Questa esperienza si ottiene con un tipo di meditazione, il fondamento da cui partono le attività di formazione estetica e delle forme da essa prodotte. Queste considerazioni ci pongono di fronte a un grande problema. Se per produrre e comprendere opere ed esperienze artistiche è necessaria l’esperienza del vuoto ottenibile attraverso la meditazione, un gran numero di persone che desiderano “comprendere” forme d’arte e di estetica orientali, viene tagliato fuori. Chi può ritenere necessaria la meditazione per assimilare queste arti ?
Ancor più insostenibile ritenere che taluni si rendano disponibili ad affrontare dure discipline di pratiche meditative per meglio capire forme e contenuti generati da queste esperienze.
Però, in ogni caso, pur non arrivando a tanto, rimane il fatto – lontano dai nostri concetti usuali – che queste arti sono esercizi di meditazione di per sé, perché hanno al centro della loro attenzione il vuoto con tutta la sua efficacia e forte presenza.
Il teorico della calligrafia Cheng Yao Tian (din. Ching), afferma:
“la via della calligrafia è fondata sulla padronanza del vuoto. E’ proprio grazie al vuoto che Sole e Luna si muovono, che le stagioni succedono; è da esso che procedono i diecimila esseri. Tuttavia il Vuoto non si manifesta e non opera se non mediante il Pieno”.
E’ grazie al vuoto, creato fuori e dentro di noi, che possiamo “comprendere”, ovvero prendere dentro. Il vuoto quindi è vita, è pulsante, creativo.

IL VUOTO NEL SUISEKI
Nelle pietre giapponesi, il vuoto è poco colore, poco movimento, poca enfasi rappresentativa. Si pratica una riduzione cromatica, e il mondo minerale e vegetale nella ricchezza dei suoi colori non è visibile. La varietà dei grigi fino al nero, e le varie altre combinazioni cromatiche che possiamo ritrovare, servono a sostituire “in modo povero “ l’infinità dei toni nei panorami delle varie stagioni.
L’arte del suiseki avvicina esplicitamente non solo quella dei giardini karesansui, ma anche quella del sumi-e, il dipinto di inchiostro e acqua.
Il legame tra pittura monocroma è riscontrabile sia per gli spazi bianchi (vuoto) che accolgono i grigi ed i neri, paragonabili allo spazio vuoto monocromo di fondale ” il tokonoma ” dove il disegno della pietra si iscrive , sia perché la pietra si offre come cosa “da vedere” e contemplare, come un dipinto o una calligrafia.

La pietra inoltre, come oggetto non percorribile (a differenza dei giardini) dove non è possibile “entrare”, obbliga a farsi vuoti perché essa possa entrare nella nostra mente.
Cosa può voler dire questo? Quando osservo una pietra lo posso fare da vari punti, con varie angolazioni, resto ferma ma nel contempo cammino, salgo, scendo. Posso entrare nei particolari: grotte, gole, risalire torrenti, sostare sulle rive di un lago o del mare. Poi, dove la sabbia incontra la pietra, scorgere ombre da essa prodotte ed addentrarmi nell’oscuro. Tutto questo mi permette di fare una semplice sostituzione tra il camminare “fisico” e quello “mentale”. Ma non è finita qui.

Una pietra è un oggetto da meditazione cioè su cui meditare. Rappresenta una prova per “testare” e valutare la capacità raggiunta a far vuoto nella mente di chi la osserva e la contempla. Più si è capaci a creare spazio con la pulizia della meditazione, più si trova posto per ospitare la pietra. Formare questo vuoto mentale è necessità per introdurre la pietra nella propria esperienza. Come l’arte del suiseki interpreti in modo quasi perfetto la disciplina Zen, si può dedurre dal pericolo indicato da vari maestri Zen di fissarsi su un obiettivo da raggiungere.
Si tratta di sforzi artificiosi perché richiedono accorgimenti tecnici e l’obiettivo di un risultato talora rende ciechi e solo focalizzati su un fine. “Ottenere è non ottenere”, dice Lin Chi .
Ciò che conta è ottenere senza l’ossessione del desiderio del raggiungimento. Questa fissazione può interferire nell’ opera del bonsaista tesa al conseguimento di un risultato tecnico ed estetico.
Nell’arte delle pietre, al contrario, siamo tenuti ad accogliere un ‘opera della natura, non a elaborarla.
L’uomo è troppo orgoglioso per prendere in considerazione le cose di immediata evidenza che lo circondano. Non si tratta di oggetti sfasciati, logori, esausti, ma impregnati di vita, non solo della propria ma di tutte le esistenze e di quei contatti che li hanno toccati. Contatti che sono serviti a non solo consumarli ma anche a pulirli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA





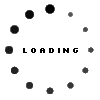
No Comment